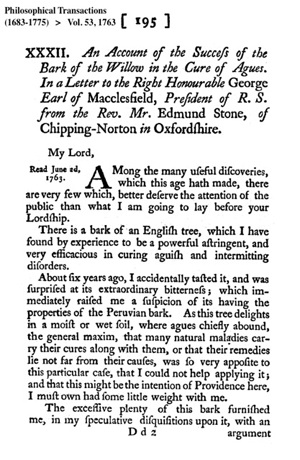Il Natale è alle porte, l'inverno è appena arrivato, il freddo inizia a farsi sentire e così tutti quei malanni che sembrano non aspettare altro che rovinarci le feste con il loro carico di nasi colanti, mal di gola, febbre e malesseri vari.
Fortunatamente ci basta prendere una pillola per evitare di passare il cenone di Natale a letto e poterci godere le infinite portate di cibo che vanno avanti dirette fino al pranzo del giorno dopo e il solito zio un po' alticcio che racconta barzellette; eppure non sono neanche duecento anni (119 per l'esattezza) che tutto questo è possibile, pochissimi, se ci pensate, nella storia dell'umanità.
 |
| salix alba |
Sicuramente raffreddori, dolori e febbri varie erano un bel problema anche per gli antichi Egizi, e non solo perché andavano a rovinare le feste, ma perché in un'epoca in cui antibiotici e vaccini erano ancora lontanissimi, una febbre troppo alta poteva portare alla morte; qualcuno, però, si accorse che riducendo in poltiglia le foglie di un albero, il Salix Alba, comunemente noto come Salice Bianco o Salice Piangente, era possibile abbassare la febbre e curare i gonfiori.
Più tardi anche il medico greco Ippocrate si accorse che le foglie del Salice avevano proprietà analgesiche e antipiretiche e le raccomandò alle donne per alleviare i dolori del parto.
Nel medioevo, i decotti di foglie di Salice erano usati per abbassare la febbre e sono stati persino inclusi nella farmacopea tedesca.
Il merito va tutto ad una molecola importantissima, fra le più famose e importanti nella storia dell'uomo: la Salicina.
 |
| salicina |
Chimicamente parlando è un β-glucoside, cioè una molecola costituita da uno zucchero legato (in quella che viene chiamata posizione β) con un'altra molecola, in questo caso l'anello aromatico della Saligenina. Non si trova solo nella corteccia del Salice, ma anche nella Viola e soprattutto nell'Olmaria, una pianta della famiglia delle Rosacee.
La Salicina è quella che viene definito un profarmaco, cioè nel nostro organismo non agisce come salicina, ma subisce delle modificazioni chimiche, infatti viene trasformata in Acido Salicilico, ed è questo ad avere la funzione farmacologica e a diventare famoso con il suo nome commerciale: Aspirina.
C'era una volta un vicario inglese
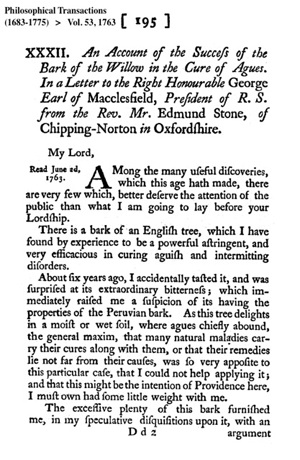 |
| Lettera di E. Stone alla Royal Society |
Il primo a pensare che un rimedio popolare potesse diventare qualcosa di molto più esteso fu Edmund Stone, un vicario inglese che, nel 1763 condusse un esperimento sorprendentemente moderno e scientifico per l'epoca.
In quel periodo andava per la maggiore la Teoria delle Signature: si credeva, cioè, che il rimedio dovesse assomigliare in qualche modo alla malattia, ad esempio per un male che colpiva lo stomaco, la pianta adatta a curarlo doveva avere una forma che ricordasse l'organo in questione il più possibile.
Basandosi su queste credenze, Stone pensò che la corteccia di Salice, una pianta che cresceva in prossimità di zone paludose, potesse curare una febbre simile alla malaria che aveva colpito molte persone che vivevano proprio in quelle zone, e che potesse avere un effetto simile a quello della corteccia di Cinchona, una pianta già usata per abbassare la febbre, ma molto più costosa.
Preparò, quindi, delle dosi di corteccia di Salice essiccata scelte empiricamente e le somministrò a 50 pazienti ogni quattro ore, documentando il tutto scrupolosamente.
I risultati ottenuti furono talmente buoni che Stone li riportò alla Royal Society di Londra, che però non fece altro che prendere atto del fatto che con questo rimedio la febbre malarica era migliorata.
Gli esperimenti di Stone furono ripresi e convalidati dal Samuel James nel 1792 che raccolse moltissimi dati e informazioni che furono utilissimi, in seguito, alla ricerca.
I coloranti e la Bayer: nasce l'aspirina
La scienza andò avanti e nel 1825 il chimico italiano Francesco Fontana isolò per la prima volta la Salicina dal Salice Bianco, nel 1828 il tedesco Johann Buchner estrasse dalla corteccia i cristalli amari di Salicina e nel giro di dieci anni chimici francesi erano riusciti a sintetizzare l'Acido Salicilico, notando che era un derivato migliore rispetto alla Salicina stessa, e la cui struttura fu poi identificata da Frederic Kolbe nel 1859.
 |
| spirea olmaria |
Insomma, l'Acido Salicilico era ormai disponibile, ma il suo sapore amaro ed effetti collaterali, in particolare il vomito, ne avevano limitato grandemente l'uso.
Dovette intervenire un ambito della chimica apparentemente del tutto slegato dal contesto farmaceutico per portare avanti la storia: l'industria dei coloranti.
Nella seconda metà dell'ottocento, l'industria legata allo sviluppo dei coloranti di sintesi era in grande crescita e moltissimi chimici lavoravano allo sviluppo di nuove molecole organiche modificando quelle già esistenti, e in particolare furono i primi a proteggere queste scoperte tramite brevetti.
La Bayer, azienda tedesca leader nel settore, decise di espandere le proprie aree di interesse anche nell'ambito farmaceutico, utilizzando come base su cui partire il gran numero di molecole che si producevano come sottoprodotti nelle sintesi dei coloranti.
Assunse, quindi, il chimico Felix Hoffman, il quale era mosso anche da interessi piuttosto personali: suo padre era infatti anziano e soffriva di artrite, ma non poteva più prendere l'Acido Salicilico a causa dei forti effetti collaterali.
Hoffman modificò l'Acido Salicilico attraverso una reazione di acetilazione e ottenne l'Acido Acetilsalicilico:
Somministrò la nuova molecola ottenuta prima a se stesso e poi a suo padre, riportando effetti più che positivi, che condussero la Bayer a testare il prodotto tramite test clinici, in cui si poté notare scientificamente un miglioramento rispetto all'Acido Salicilico usato precedentemente.
Nel 1899 la Bayer mise in commercio il nuovo farmaco con il nome di Aspirina, dalla pianta Osmaria da cui estraevano la Salicina.
P.S. come funziona?
Per decenni l'Aspirina è rimasta la regina incontrastata dei farmaci da banco, con le sue incredibili proprietà antinfiammatorie e antipiretiche, ma nessuno aveva la minima idea del suo meccanismo di azione.
 |
| aspirina |
Negli anni '60 il farmacologo Henry Collier scoprì, facendo delle ricerche in vivo su cavie animali, che, a differenza della Morfina che agiva sull'intero organismo, l'Aspirina agiva localmente. Volendone sapere di più, chiamò a lavorare con lui il biochimico John Vane perché lo aiutasse.
Attraverso esperimenti molecolari in vitro, scoprirono che l'infiammazione e il dolore (ma anche la febbre) sono modulati da molecole, impossibili da osservare in vivo, chiamate Prostaglandine.
Quello che l'Aspirina fa è inibire, cioè "spegnere", due particolari forme di un enzima, la cicloossigenasi, che ha il compito di trasformare l'Acido Arachinodico in, appunto, Prostaglandine, in mancanza delle quali non si ha né infiammazione né dolore.
Per questa scoperta, John Vane vinse il premio Nobel nel 1982, entrando quindi anche lui nella lunga storia del farmaco più famoso al mondo e aprendo le porte a nuovi e più efficaci suoi derivati.
Bibliografia:
- Wick, Jeannette. "Aspirin: a history, a love story." The Consultant Pharmacist® 27.5 (2012): 322-329.
- http://www.lescienze.it/news/2012/04/19/news/aspirina_nuovi_effetti_ampk_protein_chinasi-975546/