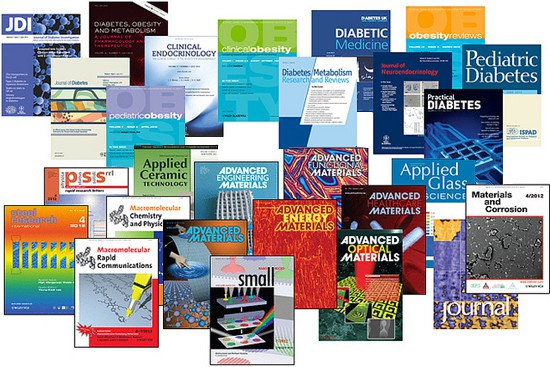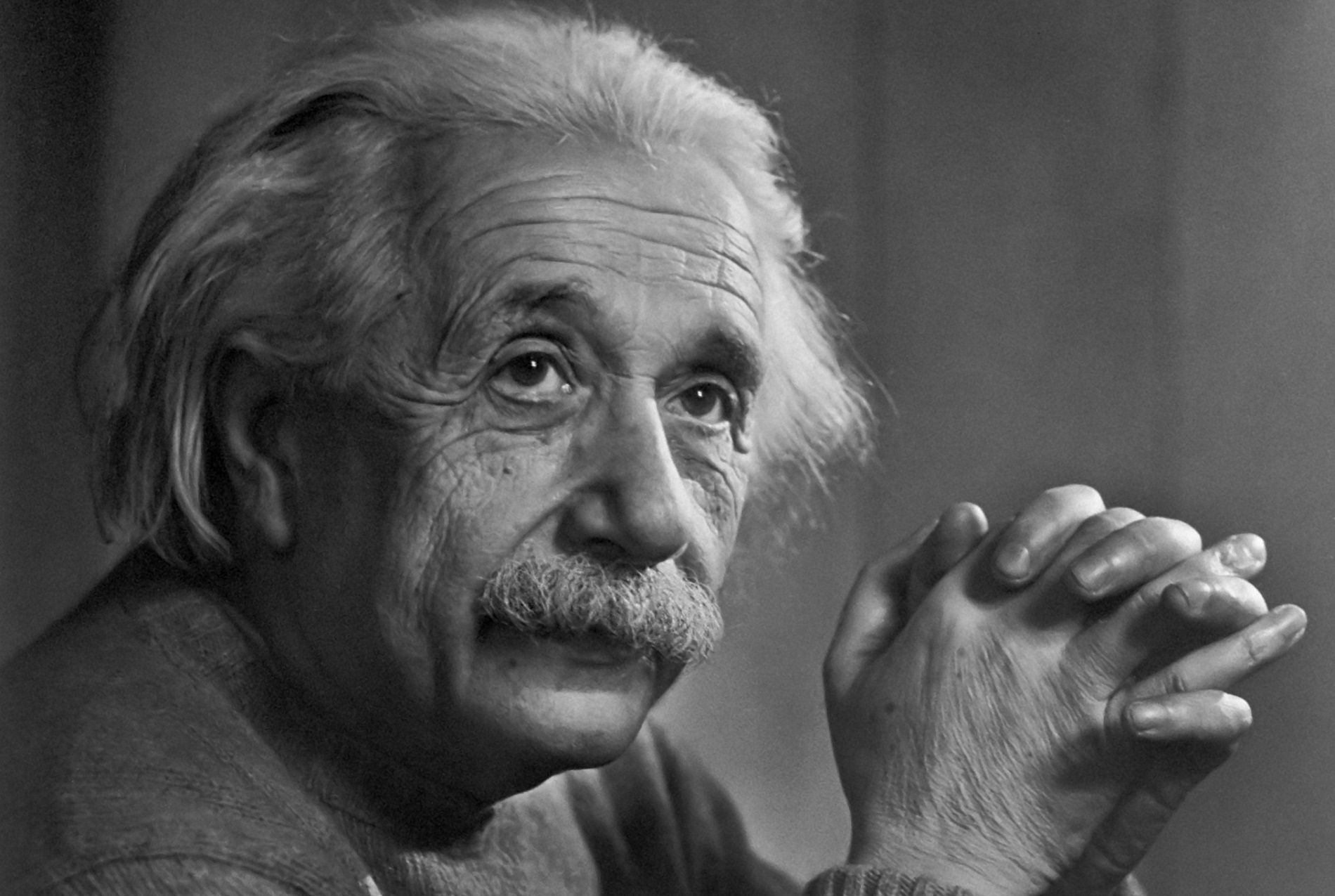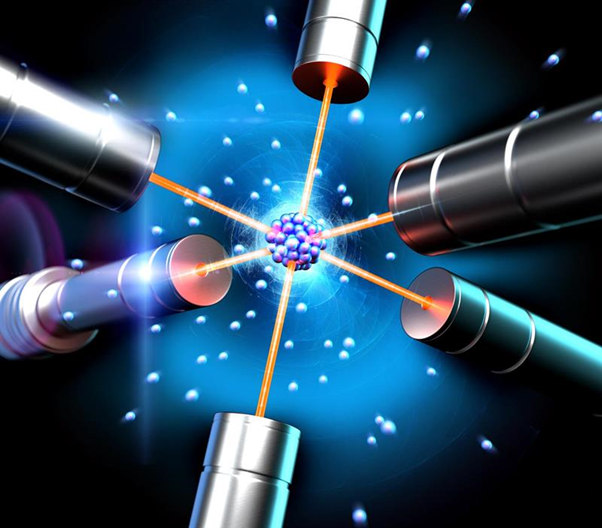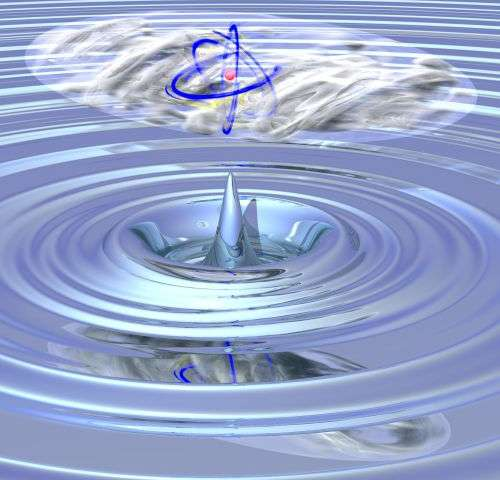Benvenuti, cari lettori, alla seconda puntata di Scienziati si diventa, la rubrica in cui entreremo nei meccanismi che sono alla base del lavoro di ogni scienziato in qualsiasi ambito, dalla medicina alla fisica delle particelle e non solo.
Dopo aver parlaro del Metodo scientifico, punto di partenza della scienza moderna e Bibbia di chiunque si approcci a questo mondo, sia esso un ricercatore o un giornalista, veniamo a un argomento citato spesso e volentieri, soprattutto nell'ultimo periodo in cui i social network (ma anche la televisione) hanno dato voce a chiunque voglia esprimere un'opinione su un qualsiasi argomento di carattere scientifico: le Fonti.
Avrete sicuramente notato che anche in questo blog, alla fine di ogni articolo, vi è una sezione bibliografica, un "per approfondire", in cui sono riportate, appunto, le fonti da cui proviene ogni parola che viene scritta.
Quando si parla di argomenti scientifici è importantissimo ricordare che quel che viene espresso non è un parere personale, o un'opinione come può esserlo l'apprezzamento per un determinato film, ma è un semplice riportare ciò che in quel determinato momento è ritenuto affidabile nella comunità scientifica. Il dibattito è perfettamente accettato, anzi, l'intera comunità scientifica è animata da un costante dibattito, in cui chiunque, anche il più giovane dei dottorandi, può controbattere e smentire la teoria di un premio Nobel, perchè non conta il nome che si porta, ma solo e unicamente i dati che si possono fornire.
Diventa, quindi, fondamentale nel barcamenarsi fra riviste divulgative più o meno famose, opinionisti dell'ultima ora e urlatori del web, scoprire qualcosa in più sulle fonti che, va ricordato ancora una volta, devono sempre essere riportate a sostegno di una qualsiasi affermazione.
Come si scrive un articolo scientifico
In genere, dopo aver portato avanti un esperimento, o meglio una ricerca scientifica (che è il risultato di molti esperimenti), si procede con lo scrivere un articolo da pubblicare su una qualche rivista del settore, di modo da rendere pubblica la propria scoperta o comunque il risultato conseguito che, ad esempio, può essere anche un risultato negativo!
Un articolo scientifico è più o meno costituito da una struttura fissa, standard, che permette quindi una consultazione più agevole:
- Titolo: il titolo di un articolo è importantissimo perchè è il primo approccio all'articolo stesso e deve quindi far capire in modo chiaro al lettore di cosa si tratterà; di fatto, più che un titolo vero e proprio, è una sorta di intestazione in cui si specifica brevemente ma esaurientemente l'argomento trattato.
- Autori: i nomi degli autori vengono riportati subito dopo il titolo e il loro ordine può essere alfabetico o, più frequentemente, per contributo, cioè viene riportato per primo il nome del ricercatore il cui contributo all'articolo è stato maggiore ed è quello che riveste più importanza, perchè nelle citazioni si usa riportare solo il primo nome seguito dalla sigla et al.
- Abstract: è un riassunto in cui vengono riportate, senza commento o osservazioni di sorta, tutti gli aspetti fondamentali del lavoro e deve rispettare un numero massimo di parole; l'abstract è fondamentale perchè di solito è l'unica parte dell'articolo liberamente fruibile e quella che ci si sofferma a leggere per capire se quel determinato articolo può essere utile o meno ai propri scopi. Subito sotto l'abstract si trova un elenco di parole chiave utili alla ricerca web o cartacea e la classificazione tematica in base alla disciplina a cui il lavoro appartiene.
- Introduzione: un breve paragrafo in cui vengono illustrati gli scopi della ricerca, le conoscenze attuali in quel dato ambito e gli articoli precedenti da cui si è partiti per sviluppare il lavoro.
- Materiali e Metodi: dove vengono elencati tutti i materiali utilizzati per portare avanti quella ricerca, gli strumenti, le procedure relative; ad esempio per una ricerca in ambito chimico verranno riportate le sostanze chimiche utilizzate, i solventi, le strumentazioni e i processi con i quali si sono ottenuti i reagenti e le formule matematiche usate per analizzare i dati. L'importanza di questa parte dell'articolo risiede nel metodo scientifico stesso (scientificità): riportare fedelmente materiali e metodi utilizzati permette a chiunque voglia farlo di poter riprodurre l'esperimento con le stesse condizioni di quelle dell'articolo (riproducibilità), ed eventualmente di confutare i risultati ottenuti dagli autori (confutazione scientifica).
- Risultati e discussione: vengono qui riportati i risultati ottenuti, i dati raccolti, tutti i grafici e le misurazioni effettuate durante l'esperimento, e questi vengono discussi e interpretati sulla base delle ipotesi che si erano fatte prima di cominciare l'esperimento e su quanto ci si poteva aspettare e quello che, poi, si è ottenuto.
- Conclusioni: viene qui effettuata una considerazione finale sul lavoro svolto, basandosi sui dati raccolti e sull'interpretazione che se ne è fatta nella discussione si giunge quindi a un epilogo esaustivo, basandosi anche sulle conoscenze pregresse, le evidenze sperimentali e le conoscenze generali in quella data disciplina.
- Riferimenti: è la bibliografia, in cui vengono riportati tutti gli articoli e i testi che sono stati presi in considerazione durante la ricerca e durante la stesura del lavoro, vengono riportati anche i manuali dei programmi e degli strumenti utilizzati, passaggi matematici particolarmente complicati per essere riportati durante la discussione, conversioni di unità di misura o anche enti e persone che hanno contribuito non scientificamente alla stesura dell'articolo.
Peer Review: revisione alla cieca
Prima di essere pubblicato, un articolo viene sottoposto a una revisione detta cieca, che gioca un ruolo di primaria importanza all'interno della comunità scientifica ed è ancora oggi, nonostante non sia sempre perfetto, il metodo più valido per poter controllare la validità di una ricerca.
Questo metodo è attivo da più di trecento anni (si stima che fu The Philosophical Transactions of the Royal Society il primo testo a esservi sottoposto) ed è ancora la colonna portante di ogni processo di pubblicazione scientifica.
Consiste sostanzialmente, come dice il nome stesso, in una revisione dell'articolo effettuata da esperti del settore specifico di cui quell'articolo tratta. Essi non conoscono gli autori nè gli altri revisiori e allo stesso modo gli autori non sanno chi sono i revisori.
 |
| Processo di revisione |
In realtà non sempre vi è questa anonimità reciproca e possiamo quindi distinguere tre diversi tipi di peer review:
- Single blind review: i revisori sono anonimi, ma sono conosciuti gli autori
- Double blind review: sia i revisori che gli autori sono anonimi
- Open review: sia i revisori che gli autori sono conosciuti
Durante il processo di revisione sono esaminati tutti i dati, i grafici, i metodi utilizzati, in modo da ridurre al minimo gli errori e prevenire l'uscita di articoli non corretti o, peggio, falsi.
Indici Bibliometrici
Ora sappiamo riconoscere un articolo scientifico e notare la differenza con un articolo qualsiasi di un giornale di divulgazione, sappiamo come viene scritto e in che modo si procede alla pubblicazione su una rivista scientifica. Ma come fare a capire se la fonte riportata nel nostro periodico preferito è affidabile? Se possiamo fidarci di quanto viene detto oppure se dobbiamo diffidare?
In genere una prima avvisaglia sta nella quantità delle fonti riportate: un giornalista serio deve sempre riportare più fonti prima di affermare con sicurezza qualcosa, perchè non basta che quel tale dato sia scritto in un solo articolo scientifico, proprio perchè la peer rewiew non è perfetta e qualcosa può sempre sfuggire.
Un altro importantissimo aspetto da considerare, è la Bibliometria. Questa è un ambito di studio applicato alle varie discipline scientifiche che utilizza modelli matematici e statistici per analizzare la distribuzione delle pubblicazioni e il loro impatto all'interno della comunità scientifica. Il primo metodo, che è un metodo qualitativo, è proprio il peer review, ma accanto a questo vi è anche un secondo metodo, questa volta quantitativo, che permette di stimare a livello numerico l'impatto e l'importanza che una data rivista e un dato articolo hanno nella comunità scientifica.
Il cardine su cui si basa la bibliometria è l'Analisi Citazionale, cioè l'analisi delle citazioni nella produzione scientifica per stabilire connessioni fra vari lavori e vari ricercatori: è quindi l'esame delle frequenza con cui un certo lavoro viene citato all'interno di articoli e in generale all'interno di testi scientifici.
Possiamo distinguere due principali modelli di analisi citazionale:
Esistono inoltre altri modelli meno diffusi, come l'Eigenfactor (EI) che tiene conto dei diversi standard di citazione tra una disciplina e l'altra, oppure il Publish or Perish (PoP) che consente di calcolare indici bibliometrici di uno specifico autore.
In genere una prima avvisaglia sta nella quantità delle fonti riportate: un giornalista serio deve sempre riportare più fonti prima di affermare con sicurezza qualcosa, perchè non basta che quel tale dato sia scritto in un solo articolo scientifico, proprio perchè la peer rewiew non è perfetta e qualcosa può sempre sfuggire.
Un altro importantissimo aspetto da considerare, è la Bibliometria. Questa è un ambito di studio applicato alle varie discipline scientifiche che utilizza modelli matematici e statistici per analizzare la distribuzione delle pubblicazioni e il loro impatto all'interno della comunità scientifica. Il primo metodo, che è un metodo qualitativo, è proprio il peer review, ma accanto a questo vi è anche un secondo metodo, questa volta quantitativo, che permette di stimare a livello numerico l'impatto e l'importanza che una data rivista e un dato articolo hanno nella comunità scientifica.
Il cardine su cui si basa la bibliometria è l'Analisi Citazionale, cioè l'analisi delle citazioni nella produzione scientifica per stabilire connessioni fra vari lavori e vari ricercatori: è quindi l'esame delle frequenza con cui un certo lavoro viene citato all'interno di articoli e in generale all'interno di testi scientifici.
Possiamo distinguere due principali modelli di analisi citazionale:
- Impact Factor (IF): è, una misura del numero di citazioni dei lavori pubblicati in una certa rivista rispetto al numero totale di lavori pubblicati dalla stessa rivista negli anni precedenti, sia a livello nazionale che internazionale. Pur essendo ancora oggi il modello più utilizzato, non è esente da alcune critiche, infatti non sempre un numero elevato di pubblicazioni è sinonimo di elevata qualità, ma in generale è un modello che riesce a essere abbastanza affidabile soprattutto per determinare l'importanza di una certa rivista. Un IF elevato, infatti, implica che un articolo, per poter essere pubblicato su quella rivista, debba avere caratteristiche particolari e la selezione sarà più ardua.
- Indice di Hirsch (H-Index): proposto nel 2005 da Jorge E. Hirsch della University of California di San Diego, quantifica la prolificità e l'impatto del lavoro di un ricercatore in base al numero di pubblicazioni fatte e di citazioni ricevute e al contrario di quanto avviene con l'IF prescinde dal considerare un solo articolo di grande successo oppure una quantità molto alta di articoli di scarso interesse. Una sua variante è l' h-b-index (Hirsch-Banks Index) che sostituisce al nome dello scienziato uno specifico argomento o composto.
Esistono inoltre altri modelli meno diffusi, come l'Eigenfactor (EI) che tiene conto dei diversi standard di citazione tra una disciplina e l'altra, oppure il Publish or Perish (PoP) che consente di calcolare indici bibliometrici di uno specifico autore.
L'IF è al momento l'indice di riferimento quando si parla di classificazione delle riviste scientifiche, ne va una sorta di classifica per importanza. Naturalmente sarebbe sbagliato considerare l'IF come la Legge o la Verità assoluta, anche perchè quantità e qualità sappiamo non andare sempre d'accordo, ma in generale meglio un articolo comparso su Nature che quello del giornalino della scuola che nessuno ha controllato.
Per approfondire:
- https://www.elsevier.com/reviewers/what-is-peer-review
- http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/bd/per_chi_pubblica/archivio/indicatori-bibliometrici
- http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=623&lang=it
- Garfield, Eugene. "Journal impact factor: a brief review." Canadian Medical Association Journal 161.8 (1999): 979-980.
- Bornmann, Lutz, Rüdiger Mutz, and Hans‐Dieter Daniel. "Are there better indices for evaluation purposes than the h index? A comparison of nine different variants of the h index using data from biomedicine." Journal of the Association for Information Science and Technology 59.5 (2008): 830-837.
- https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2018.00037/full